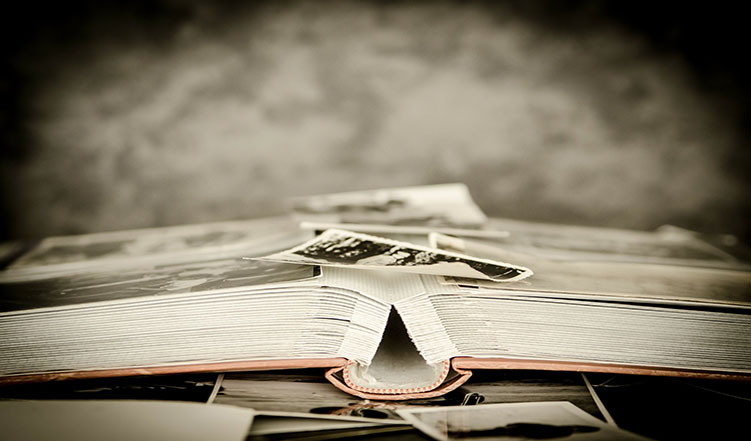CHE COS’È LA MEMORIA?
La memoria è quel processo psichico che consente all’individuo di immagazzinare, conservare e recuperare informazioni (Galimberti,1999).
La memoria viene considerata come il prodotto di 3 distinti momenti: una prima fase di acquisizione, in cui si apprendono le informazioni; una fase di ritenzione, dove le informazioni vengono mantenute in memoria; e infine, la fase di recupero, dove vengono richiamate le informazioni (Moderato Rovetto, 1997).
La memoria dunque è un complesso processo che richiede un’attiva rielaborazione di contenuti piuttosto che una passiva ricezione di essi. Questo implica che il contenuto recuperato sia una ricostruzione, piuttosto che un’accurata e fedele rievocazione dell’informazione originaria.
Numerosi studi recenti suggeriscono che i diversi stadi della memoria sono mediati da diverse strutture cerebrali. La più sorprendente viene da studi di imaging cerebrale, indicanti che la maggior parte delle aree cerebrali che si attivano durante la codifica o acquisizione si trova nell’emisfero sinistro, e che la maggior parte delle aree che si attivano durante il recupero si trova nell’emisfero destro (Shallice et all.1994).

MODELLI TEORICI:
Storicamente i modelli teorici che hanno studiato la memoria sono 3:
1) l’Associazionismo con la Teoria dell’oblio di Ebbinghaus (Germania, 1885);
2) il Costruttivismo con la teoria di Bartlett (Inghilterra, 1932);
3) il Cognitivismo (USA) con la Teoria dei magazzini di memoria di Atkinson e Shiffrin (1968), La memoria episodica e semantica di Tulving (1972) e la Teoria della memoria di lavoro di Baddley (1986).
1)Gli studi sulla memoria sono iniziati con Ebbinghaus (1885) che ha descritto la curva di ritenzione e dell’oblio, per analizzare e studiare le forme di associazione tra stimoli utilizzò dei trigrammi senza senso, per evitare le influenze logico-linguistiche, e la ripetizione seriale che si basa sul concetto di esercizio secondo il quale è solo la pratica che favorisce e migliora l’apprendimento.
2)Il Modello Costruttivista di Bartlett (1932), pone l’accento sul ruolo determinante delle operazioni compiute dal soggetto. Si occupa di memoria in rapporto a situazioni realmente vissute, il processo mnestico è il prodotto di una ristrutturazione in cui il soggetto impiega strategie attive di ricostruzione della traccia mnestica in base al confronto e all’integrazione con le informazioni già presenti in memoria.
Lo strumento utilizzato da Bartlett era quello del breve racconto.
Egli fu il primo a studiare gli effetti degli schemi sulla memoria e suggerì che quando tentiamo di far corrispondere i racconti agli schemi, possono verificarsi distorsioni della memoria molto simili a quelle che avvengono a quando facciamo corrispondere le persone agli stereotipi.
3)Il Modello di Atkinson e Shiffrin (1968), è visto come una metafora del funzionamento del computer: la mente umana poteva essere assimilata alle operazioni svolte da un calcolatore. Da ciò deriva la concezione dell’uomo come elaboratore di informazioni Human Information Processing.
Il modello prevedeva 3 stadi, da qui il nome di Teoria Tripartita della Memoria, corrispondenti a tre rispettivi magazzini di memoria.
Il primo comprendeva un registro sensoriale (Sperling, 1963) in grado di catturare l’informazione in entrata e di trattenerla per un brevissimo periodo di tempo che varia da pochi decimi di secondo a pochi secondi. Da qui l’informazione veniva inviata a un magazzino di memoria a capacità limitata o Memoria a Breve Termine MBT ed infine trasferita ad un ultimo magazzino per la definitiva archiviazione il Magazzino a Lungo Termine MLT.
MEMORIA A BREVE TERMINE
Nel magazzino di MBT l’informazione è facilmente accessibile ma è soggetta a decadimento in circa 20 sec. È possibile impedire il decadimento della traccia mediante la ripetizione, inoltre, l’informazione contenuta nella memoria a breve termine può essere sottoposta ad altri tipi di processi di elaborazione al momento del trasferimento al magazzino a lungo termine.
MEMORIA A LUNGO TERMINE
Il magazzino a lungo termine MLT ha una capacità illimitata ed opera ad intervalli di tempo che vanno da alcuni minuti ad anni.
Nella memoria a lungo termine l’informazione è codificata sulla base del significato. Quanto più è approfondita è la codifica del significato, tanto migliore sarà la risultante memoria (Craik e Tulving, 1975).
L’oblio nella memoria a lungo termine è dovuto a incapacità di recupero ma soprattutto ad interferenza di nuove informazioni.
L’informazione nella memoria a breve termine tende ad essere codificata acusticamente sebbene possiamo utilizzare anche un codice visivo (Conrad,1964).
L’esistenza di codici sia acustici che visivi ha portato i ricercatori a concludere che la memoria a breve termine possiede diversi sottosistemi o “buffer”.
MEMORIA DI LAVORO
Partendo da questa idea Baddeley (1986) sviluppa il modello della Memoria di Lavoro o Working Memory. Costituita da un esecutivo centrale, che rappresenta la parte principale e sovraintende soprattutto compiti de ragionamento e decisione. Essa inoltre, svolge la funzione di supervisione nei confronti di 2 sottosistemi definiti: processo articolatorio, coinvolto nell’immagazzinamento e nell’elaborazione del materiale verbale e il magazzino visuo-spaziale, la cui funzione consiste nell’immagazzinamento e nell’elaborazione del materiale visuospaziale. Recentemente Baddeley (2000) ha riconosciuto la necessità di aggiungere un ulteriore componente della memoria di lavoro chiamato buffer episodico la cui funzione sarebbe quella di legare o associare i diversi aspetti di un ricordo.
La capacità mnestica del magazzino acustico o processo articolatorio è limitata a 7+-2 chunks (Miller,1956). La quantità d’informazione nella memoria di lavoro può essere aumentata incrementando la quantità di informazioni in ogni singolo chunK, ad esempio raggruppando sequenze di lettere in unità significative come le parole.
Inoltre, la ricerca ha dimostrato che quanti più elementi si trovano nella memoria a breve termine tanto più lento diventa il recupero (Sternberg,1966).
La memoria a breve termine gioca un ruolo importante nel pensiero.
Dato il suo ruolo nei calcoli mentali i ricercatori spesso definiscono la memoria a breve termine come “memoria di lavoro”, concependola come una lavagna sulla quale la mente esegue i calcoli (Baddeley, 1986).
La memoria a breve termine si utilizza anche per risolvere analogie geometriche e capacità di rispondere a domande sul testo.
Dall’inizio degli anni Settanta fino alla fine degli anni 80 il panorama scientifico relativo agli studi sulla memoria si è arricchito ulteriormente di nuovi contributi.
MEMORIA DICHIARATIVA E PROCEDURALE
Tulving (1972), fece un’altra distinzione importante tra memoria dichiarativa o esplicita e memoria procedurale o implicita. La prima è quella di cui noi siamo consapevoli. La seconda è quella forma di memoria a cui non possiamo accedere consapevolmente. La memoria dichiarativa si divide ulteriormente in memoria episodica e memoria semantica.
La memoria episodica riguarda la codificazione, l’organizzazione ed il recupero di episodi particolari della vita autobiografica che hanno una collocazione spazio-temporale.
La memoria semantica, invece, riguarda le informazioni che non hanno una prospettiva spazio-temporale, comprende le nostre conoscenze in generale.
Un’alternativa alla teoria di Atkinson e Shiffrin è:
La Teoria della Profondità della codifica di Craik e Lokhart (1972) sostiene che la durata della traccia nella memoria dipenda dalla profondità con cui lo stimolo è stato elaborato nella fase di codifica. Ipotizza 3 livelli di elaborazione: strutturale, fonemico e semantico.
Gli stimoli soggetti ad un’analisi più profonda cioè semantica sono ricordati in misura significativamente maggiore.
VALUTAZIONE DELLA MEMORIA: QUALI TEST?
Trai i Test che studiano e valutano la memoria molto utilizzata è la Wechsler Memory Scale (Wechsler, Stone, 1963), costituita da 7 subtest, che indagano tutti i tipi di memoria. La scala di WAIS (Wechsler, 1955) valuta sia la capacità di ritenzione di nuove informazioni sia il ricordo di materiale precedentemente appreso.
Altri due importanti test sono Il Reattivo della figura complessa e il profilo di rendimento mnestico, entrambi di Rey:
il reattivo della figura complessa (Rey, 1941) permette di distinguere i casi di insufficienza mnemonica dai problemi di organizzazione visuo-motoria;
il profilo del rendimento mnestico (Rey,1958), formato da 7 subtest più due supplementari, è utile per l’esame individuale della memoria in soggetti adulti.
Il Test di memoria comportamentale di Rivermead (Wilson et al., 1990) è uno strumento utile nell’evidenziare i deficit di memoria quotidiana e permette di seguire eventuali modifiche nel tempo dei deficit mnestici e di pazienti cerebrolesi dopo una loro eventuale riabilitazione (Bianchi, 2008).
Inoltre, una delle tecniche più semplici utilizzate per studiare la memoria consiste nel chiedere ai soggetti di studiare una lista di parole e di rievocarne il maggior numero possibile oralmente o per iscritto. In un test di rievocazione la misura della prestazione può essere data dal numero di item correttamente rievocati e/o dal numero di errori.
Per quanto riguarda la memoria verbale si può utilizzare la lista di 15 parole di Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test) dove viene letta al soggetto una lista di parole e si chiede al soggetto la loro rievocazione subito dopo (rievocazione immediata) o dopo un breve intervallo (rievocazione differita). Questo test consente di ottenere dati quantitativi e qualitativi sulla memoria verbale in quanto conteggia il numero di parole rievocate e la loro posizione nella lista. Con questo si può notare l’effetto primacy e l’effetto recency, relativi alla tendenza al maggiore ricordo delle prime e ultime parole della lista.
Per indagare la memoria uditivo-verbale si utilizza il Test della memoria di prosa o “raccontino” di Spinler e Tognoni , incluso in una batteria per la valutazione del deterioramento cognitivo MODA (Milan Overall Dementia Assessment) costituito da diversi sub test.
Infine, per la valutazione della memoria visuospaziale è spesso utilizzato il Test di Corsi, costituito da una tavoletta con 9 cubetti. L’esaminatore tocca i cubetti secondo un ordine che successivamente il paziente deve riprodurre nello stesso ordine.
“Se pensi che la tua memoria non funziona più come prima, rivolgiti ad un professionista per una valutazione. Solo un professionista con le sue competenze è in grado di darti le risposte che cerchi”.
ESERCIZI PER LA MEMORIA
La Teoria di Atkinson e Shiffrin suggerisce di memorizzare i contenuti mediante la ripetizione così da favorirne il passaggio dalla Memoria a Breve Termine a quella a Lungo Termine, mentre le osservazioni di Craik e Lokhart suggeriscono di approfondire il materiale, di organizzarlo gerarchicamente, di ordinarlo ed integrarlo con conoscenze pregresse, rielaborarlo e di connotarlo emotivamente in modo da ottenere una memorizzazione a lungo termine meno meccanica e passiva.
Nella scuola si sta diffondendo l’utilizzo di metodi di memorizzazione del materiale (verbali o visivi) con l’intento di potenziare le capacità mnestiche di soggetti che presentano problemi di apprendimento. Esempi tipici di tali tecniche sono gli acronimi (parole artificiali le cui componenti rappresentano dei suggerimenti per ricordare ciò che si deve memorizzare) e gli acrostici (frasi in cui le lettere iniziali di ogni parola corrispondono al termine da ricordare).
Athinson e Raugh hanno elaborato una tecnica per apprendere le lingue straniere (metodo della parola chiave) che consiste nell’associare una parola foneticamente simile alla parola straniera da ricordare e si costruisce un’immagine mentale che collega i significati delle due parole. Tra le tecniche di associazione visiva, la più comune è la link system che consiste nel costruire un’immagine visiva di ciascun item da apprendere e nel metterli in relazione l’uno con l’altro.
I metodi, indicati come mnemotecniche, sono finalizzate a favorire un uso più efficiente della funzione mnestica. La loro utilità consiste nel fornire uno schema per organizzare le informazioni mettendo in rapporto rapidamente ed efficacemente le nuove informazioni con quanto già immagazzinato. I sistemi e le tecniche possono essere divisi in verbali e visivi. Una delle tecniche verbali più note è la Rima. L’ultima tecnica verbale è la Parola Chiave che consente un produttivo immagazzinamento e il successivo recupero di vocaboli di lingue straniere e di nomi propri.
Riguardo ai sistemi di memoria il più completo è il metodo fonetico che consente sia il ricordo di lunghe serie di item nell’esatto ordine di presentazione, sia il ricordo di numeri con molte cifre.
I metodi visivi si basano, invece, sull’uso di immagini mentali. Tra le tecniche ricordiamo le storie che consistono nel creare una sorta di racconto dotato di significato e le associazioni visive, una delle più comuni consiste nel creare delle catene di item in cui si costruisce un’immagine vivida di ciascun item da apprendere e legarli.
Mentre ai sistemi è possibile ricondurre la mnemotecnica dei Loci e il Peg Sistem.
Il primo è un sistema antico utilizzato da Cicerone che consiste nello scegliere dei luoghi relativi ad un percorso abituale e nel creare un’associazione tra gli item da apprendere e i luoghi.
Il peg system consente un rapido recupero di informazioni seriali, ciascuna parola di una filastrocca è un aggancio a soli 10 item da ricordare.
L’ambito dove la memoria è regina è la neuropsicologia che studia e valuta le funzioni cognitive e predispone percorsi riabilitativi per deficit mnestici dovuti a deterioramento, traumi o lesioni cerebrali. Le amnesie sono caratterizzate da marcata compromissione della capacità di ricordare nuove informazioni apprese dopo l’esordio (amnesia anterograda); grande difficoltà a ricordare eventi precedenti all’amnesia (amnesia retrograda). I deficit di memoria possono essere di natura diversa, psicogena come nell’amnesia dissociativa, oppure il sintomo di una patologia da intossicazione è questo il caso della Sindrome di Korzakoff, causa di abuso alcolico, o di una malattia di carattere neurodegenerativo come nel Morbo di Alzheimer.
Attraverso il Memory Training è possibile recuperare parzialmente o totalmente i deficit o quantomeno organizzare in routine le proprie abitudini in modo da minimizzare l’impatto del deficit mnestico nella quotidianità.
In quanto esperta in Neuropsicologia mi occupo di Valutazione della memoria utilizzando i test che ho sopra citati e di Memory Training, applicando molte delle tecniche che ho cercato di presentarti.
Hai un problema di memoria?
CONTATTAMI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.
Bibliografia:
- Atkinson RC.& Shiffrin RM. Human memory: a proposed system and its control processes. Psychology of learning and motivation. Volume 2, 1968, 89-195
- Baddeley A. The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences Volume 4, Issue 11, 2000:417-423
- Baddeley, A. Working memory. Clarendon Press/Oxford University Press, 1986
- Bartlett F.C. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge University Press, Cambridge, 1932
- Brazzelli M. et al. (1993) “Taratura della versione italiana del Rivermead Behavioural Memory Test: un test di valutazione ecologica della memoria”, Bollettino di Psicologia Applicata, 206:33-42
- Caffarra P. et al. (2002) “Rey-Osterrieth Complex Figure: Norm. Val in an Italian pop sample”, Neurological Scienc., 22:443-447
- Carlesimo G.A. et al. (2002) “Standard. di due test mem per uso clinico. Breve Racconto e Figura di Rey”, N.R.Neurol., 12(1):1-13
- Conrad R. Information, acoustic confusion and memory span. British Journal of Psychology, 1964: 429-432
- Craik FIM. & Lockhart rs. Levels of processing: a framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. Volume 11, Issue 6, 1972:671-684
- Craik, F. I. M., & Tulving, E. (1975). Depth of processing and the retention of words in episodic memory. Journal of Experimental Psychology: General, 104(3), 268–294.
- Ebbinghaus H. Über das gedächtnis: untersuchungen zur experimentellen psychologie. 1885
- Galimberti U.Psicologia Le garzantine. Garzanti, 1999
- MBT: DIGIT SPAN E SPAN DI CUBI (CORSI) Orsini A. et al. (1987) “Verbal and Spatial immediate memory span: normative data from 1355 adults and 1112 children”, Italian J Neurological Sciences, 8:539-548
- Mecacci L. (a cura di), Manuale di psicologia generale. Giunti, Firenze 2001.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63(2), 81–97
- Moderato, P., Rovetto, F. (1997). Psicologo: verso la professione. Milano: McGraw-Hill.
- Novelli G. et al. (1986) “Tre test clinici di mem. Verb. a LT. Taratura su soggetti normali”, Arch Psic Neur Psich, 47(2):278-296
- Shallice T. et all. Brain regions associated with acquisition and retrieval of verbal episodic memory. Nature, 1994: 633-635
- Sperling G. A model fir visual memory tasks. The journal of the human factors and ergonomics society, 1963.
- Sternberg, S. (1966). High-speed scanning in human memory. Science, 153(3736), 652–654.
- Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving & W. Donaldson, Organization of memory. Academic Press
- Wechsler, D. (1963). Engrams, memory storage, and mnemonic coding. American Psychologist, 18(3), 149–153.
- Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DSA, cosa sono? - 1 Aprile 2023
- Apprendimento: Definizione, Principali Teorie e Implicazioni Cliniche - 5 Ottobre 2022
- Non ho più voglia di vivere: pagina di un diario - 20 Giugno 2022